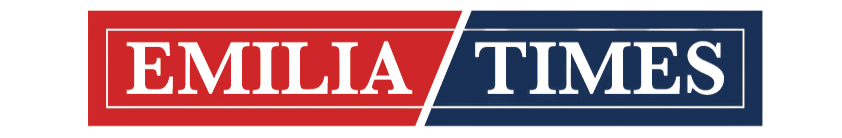Parlo molto, da sola, a voce alta media o bassa, nella mente o con qualcuno. Molti dei miei dialoghi sono inerenti al mio lavoro, a ciò che ho fatto e a come poter migliorare la volta dopo. Mi pongo domande e spesso mi rispondo da sola. Mi capita quando in auto torno a casa da una giornata intensa di lavoro, mi interrogo insieme ai miei colleghi operatori sociali mentre siamo in pausa pranzo oppure a fine turno mentre ci dirigiamo verso il parcheggio. Ci interroghiamo sul nostro operato del giorno e del giorno a seguire. Fino a che punto interveniamo e in quale modo? Qual è la linea sottile che divide l’educare e l’assistere? Sicuramente questo è uno dei nodi intensi e principali nel lavoro dell’educatore. Se ci si riflette attentamente tutto ruota attorno all’autonomia, al raggiungimento di obiettivi, alla crescita ed al lavoro personale che si attua per il futuro.

Quando si parla di educazione occorre sicuramente, prima o dopo, fare riferimento al raggiungimento di un’autonomia. Autonomia che è raggiungibile tramite l’insegnamento, le dimostrazioni, gli sbagli, le ripetizioni, i continui e numerosi nuovi sbagli, i quasi traguardi… e dopo qualche altra ricaduta potremmo osservare con soddisfazione, tantissima soddisfazione il raggiungimento del traguardo. Il traguardo è prendere un mezzo di trasporto ed arrivare a destinazione, il traguardo è prenotare un appuntamento per una visita medica oppure chiedere informazioni ad un ufficio pubblico; noto un sudatissimo traguardo nel rispettare gli orari degli appuntamenti e nel raccogliere tutta la documentazione corretta e necessaria per una determinata questione. Potrei andare avanti per ore…
La pazienza e la passione che ci si mette ad educare una persona all’autonomia sono estremamente silenziose e invisibili agli occhi di chi non è all’interno del rapporto educatore/educando; paragono questo lavoro a delle gocce d’acqua che poco alla volta riempiono un bicchiere. Ecco, mi sono appena resa conto che posso paragonare il traguardo ad un contenitore pieno d’acqua!
Educare all’autonomia comporta molto lavoro e molte risorse, è chiaro a tutti che sarebbe più semplice e meno dispendioso sostituire l’educando nel fare tutte queste cose. Capiamo bene che facendolo otterremmo il risultato in tempo breve, senza imprevisti e senza complicazioni.
Passiamo al sodo ed al concerto di ciò che desidero trasmettervi.
Poniamo l’esempio che la persona da educare in questione sia un richiedente asilo, un migrante, un ragazzo proveniente dal Bangladesh arrivato in Italia da 6 mesi e che sta iniziando a sperimentare il suo italiano, ha intenzione di cercare un lavoro, desidera crearsi una nuova vita. Il momento esatto in cui ci sostituiamo a lui chiamando al suo posto il suo medico per il suo mal di schiena interrompiamo ciò che potrebbe essere un tassello aggiuntivo al suo bagaglio e ai suoi nuovi saperi, evitiamo che sperimenti il suo timido e fragile italiano e cosa ancora più importante e dannosa creiamo assistenzialismo ad una persona che non ne ha bisogno.
Credo sia fondamentale perciò percepire e capire cosa, la persona che stiamo supportando, possa fare in autonomia e quali siano i suoi limiti e le sue possibili competenze.
Gran parte del mio lavoro è dare strumenti e metodologie che possano rendere possibili cose a chi strumenti e metodologie non ha. Il lavoro che metto in campo oggi con le persone che affianco mira ad un futuro, nel caso specifico privo di operatori sociali e privo di un progetto di accoglienza di supporto.
Dobbiamo dare lo spazio e la possibilità di mettersi in giorno e di sbagliare; sebbene, e sarò ripetitiva, ciò comporti tanta pazienza ma tanta passione.
di Sonia Lerose